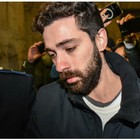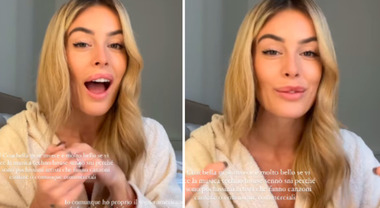Era davvero un “sabato qualunque” quel “sabato italiano” di cui cantava 40 anni fa (1983) Sergio Caputo navigando tra swing e jazz nel suo primo, omonimo album che lo consegnò alla popolarità? «Io non so come fossero quelli degli altri, posso parlare dei miei, spericolati come lo erano del resto gli altri giorni della settimana», dice il musicista romano oggi, 68 anni, alla vigilia sia della riproposta in vinile e cd (da Sony, alla quale ha ceduto il suo catalogo indipendente) di “Un sabato italiano” in versione jazz, disco col quale dieci anni fa festeggiò i 30 anni di quel fortunato esordio, sia di un tour con big band in varie città italiane (“Un sabato italiano 40 show” debutta il 12 aprile al Lirico-Gaber di Milano, poi sarà il 26 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 28 al Teatro Acacia di Napoli).
Perché “spericolati”, Caputo?
«Perché mi dividevo tra la musica e il lavoro “vero”, quello di art director di una grande azienda pubblicitaria con un cluster di clienti importanti curati proprio da me, dalla Perugina alla Heineken. Il tabellino di marcia prevedeva: mattina e pomeriggio in ufficio fino alle 18,30, ritorno a casa per dormire con sveglia impostata alle 23, schizzavo fuori dal letto e in giro tutta la notte per locali, veloce passaggio da casa poco dopo l’alba e ingresso in ufficio. Durò per qualche annetto».
Con abbiocchi durante le conversazioni con i clienti?
«Nessun abbiocco, riuscivo a conciliare perfettamente tutto, sarà stata l’età, allora giovane. L’unico stratagemma era comprare un po’ di abiti di uso quotidiano nei mercatini».
Cioè? Si spieghi meglio.
«Beh, spesso tornavo a casa con qualche ragazza incontrata nei jazz club e naturalmente era vestita da sera, con una mise appariscente. Così, l’indomani, per non far insospettire la portinaia, le davo un paio di jeans, un maglione o una gonna perché potesse affrontare più serenamente eventuali sguardi sospetti. Di solito questi indumenti non tornavano più indietro».
Magari non così avventurose tutte le notti per gli altri italiani… il sabato, forse.
«Il sabato era ancora speciale, in quegli anni Ottanta. Il mito del weekend era fortemente radicato. Gli incontri – umani e artistici – che potevi fare nei locali erano incredibili, diversi addirittura per fasce orarie: sapevi che alle undici trovavi un tipo di persone e alle due un genere assolutamente differente. E stringevi amicizia con gente comune o con personaggi fuori dall’ordinario».
Grande voglia di socialità, vera, pelle a pelle.
«Una sete di vita che ti spingeva a vivere al massimo, lo stesso casanovismo – vedi le ragazze che salivano a casa in strass e scendevano in jeans – era in effetti innocuo, una dolce vita che scacciava il timore di una possibile guerra atomica. Oggi siamo tornati a quella paura lì e la sete di vita la plachiamo guardandoci sullo schermo di un pc».
Eppure, c’è chi critica ancora oggi gli anni Ottanta come tutta apparenza e poca sostanza.
«Furono anni che invece ci spinsero fuori dal tunnel dei Settanta che nel nostro Paese in particolare erano stati di lotte sociali, politiche, violenza, terrorismo. Se poi penso a cosa è stato quel decennio dal punto di vista musicale, mi sbalordisco ancora: da Sting, uno dei più grandi artisti dei nostri tempi, ai miei due miti, Sadè e George Michael per quel che fece dell’uso delle nuove tecnologie, Anita Baker, gli Eurythmics, i Simple Minds. E potrei continuare con l’elenco…».
Chi la tirò fuori da quella “vita spericolata” divisa tra ufficio e night club?
«Il primo a credere in me fu Nanni Ricordi, qualche anno prima avevo inciso un 45 giri, gli inviai una cassetta e mi volle conoscere. Empatia immediata. La casa discografica non era già più della sua famiglia, lui era solo direttore artistico. Quando andò via, alla Cgd, mi disse “vieni con me”. Lì c’erano Franco Crepax e Alfredo Cerruti, due colonne della discografia. E soprattutto Piero Sugar e Caterina Caselli, editori illuminati, di gran fiuto. Mi diedero carta bianca».
Un altro mondo.
«Che non esiste più. Chi avrebbe mai immaginato, per esempio, 40 anni fa, che sarebbe morto il diritto d’autore con una fruizione della musica chiamata streaming? Un artista non campa certo di pensione e così devi fare concerti fino a 90 anni, quasi costretto a schiattare sul palco. Allora mi sono fatto due conti anch’io e ho venduto il mio catalogo indipendente alla Sony: da un lato ho monetizzato, dall’altro affidato la mia opera a chi, devo essere sincero, la sta gestendo con grande serietà e oculatezza».
Lei ha vissuto da indipendente gran parte della sua carriera.
«La discografia aveva contratti capestro. Usciva un album e dovevi subito lavorare a quello successivo. E poi la promozione, i tour, i Sanremo.
Eppure, di quell’esordio con “Un sabato italiano” non sembrava soddisfatto. Perché?
«Sarò sempre grato a “Un sabato italiano” perché è da lì che è partita la mia carriera. Ma, fosse stato per me, quell’album lo avrei fatto in chiave più jazzistica come era nelle mie corde e invece si virò verso il pop. Niente contro il pop e il rock, beninteso, o contro l’elettronica che allora andava di moda, ma per esempio al posto delle tastiere avrei messo una bella sezione fiati».
Si è rifatto con il remake all jazz di dieci anni fa.
«Sì, per il trentennale mi sono proprio tolto una bella soddisfazione. E sono le versioni che gli spettatori ascolteranno nel nuovo tour ma con la big band e non nella versione trio che è stata il mio mood negli ultimi anni».
C’è sempre stata un po’ di puzza sotto il naso per chi, come lei, ha scritto canzoni che sembravano spensierate ma sotto le quali un concetto magari c’era.
«Questa è un’anomalia tutta italiana. Nessuno in America è mai andato da Cole Porter, da Duke Ellington, da Fats Waller a chiedergli “scusate, com’è che scrivete anche canzonette?”. Forse perché sulla scia degli anni Settanta, da noi bisognava essere tristi a tutti i costi, bianco o nero, non c’era la mezza misura della malinconia. Io poi mi sono sempre definito un neorealista perché ho sempre scritto di cose che ho vissuto, mai di utopie, mai per metafora».
L’hanno paragonata a Fred Buscaglione.
«Errore da sottolineare con la matita blu. Buscaglione fu un grande musicista ma lui parlava di gangster, pupe, pistole, di una Chicago che era già anacronistica in quegli anni Cinquanta. Era la caricatura del malavitoso americano col gessato e il sigaro. Dovessi invece fare riferimento a un artista, per il mio modo di scrivere e cantare, quello è Natalino Otto».
A un certo punto lei decide di mollare l’Italia e andare in America dove rimane per 12 anni, 6 dei quali senza più tornare. Adesso vive in Francia. Si è forse sentito trascurato in Italia?
«Vorrei dirle di no, ma in fondo sì. L’America è stata rimettermi in gioco, battere i locali, cercare nuovi stimoli e anche scritture. È stato tornare alla chitarra che è il mio strumento mentre tutti in Italia, avendomi visto sempre al pianoforte, pensavano fosse quello. Poi sono tornato nella mia città, ho provato a vivere per qualche tempo a Roma ma con tre figli piccoli era tutto molto complicato per cui ho scelto la Francia».
In questo andare e ritornare, amici di ieri persi di vista o dileguatisi?
«Alcuni purtroppo sono scomparsi davvero. Ho paura ad accendere il pc la mattina, temo qualche brutta notizia. Con quelli storici siamo sempre in contatto: Francesco De Gregori, Eugenio Finardi, Carlo Massarini».
Le sue passioni oltre la musica sono la pittura e la cucina.
«E la scultura anche. Tanto che tra un po’ sarò costretto ad uscire dal mio studio, dove suono. ma dipingo e scolpisco pure, perché pieno di lavori grandi e piccoli che ho creato. Mi diverto anche tra i fornelli. Qui in Francia, ma non lo dica in giro, si mangia malissimo. In America hanno un solo dio, il barbecue. Per cui, se voglio trovare un po’ di soddisfazione, prendo padella e pentola e mi butto su un’amatriciana».
Ha visto l’ultimo Sanremo?
«Sinceramente no».
Eppure, lei ne ha fatti tre.
«Il primo, nel 1987, lo feci con grande piacere con “Il Garibaldi innamorato”. Avevo questa musica latina in testa ma non sapevo cosa scriverci su. Così mi venne in mente l’Eroe dei Due Mondi, il Garibaldi del Sudamerica, Anita. Il secondo festival, due anni dopo, non avrei voluto farlo ma i miei produttori insistettero: mi sentivo chiuso in una gabbia, ero per tutti “quello dello swing” mentre avevo già fatto altre cose e così portai “Rifarsi una vita”. Tra l’altro quell’anno capitò una cosa strana: mi sentii mollato dai discografici. Capii solo a fine festival che in quel Sanremo la Cgd era stata acquistata dalla Warner. E, visto che a volta la storia si ripete, la stessa cosa accadde con il terzo Sanremo, nel ’98, dove gareggiai con “Flamingo”, un brano bello ma forse non facile: in quel festival la Polygram, che era la mia etichetta, fu venduta alla Universal».
Ci tornerebbe a Sanremo?
«Se devo cantare alle due di notte, rispondo: no, grazie».
Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Marzo 2023, 14:38
© RIPRODUZIONE RISERVATA