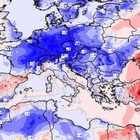Sono passati ottant’anni da quando Robert Allen Zimmerman ha aperto gli occhi sul mondo dalla sua remota visuale di Duluth (Minnesota), eppure nessuno è riuscito ancora a decifrare il suo enigma. Una sfinge, un profeta, l’oracolo di una generazione e delle sue utopie. Ma anche una maschera, insieme coerente e contraddittoria, aperta a mille interpretazioni, nessuna delle quali potrà mai risultare esatta. "Tutto quello che posso fare è essere me stesso, chiunque io sia", come lui stesso ha spiegato. E in una delle sue ultime canzoni, citando Walt Whitman, ha ribadito: “Io contengo moltitudini”.
Quel che è certo è che oggi spegnerà le candeline nella sua villa di Malibù, attivo come sempre, anzi, Forever Young, per citare la ninnananna che scrisse nel 1973 per il primogenito Jesse. Anche a costo di combattere quella fastidiosa artrite, che non gli permette più di imbracciare la chitarra, e di stemperare la sua inconfondibile voce - già descritta da David Bowie come "sabbia e colla" - in una declamazione più sommessa, come nel suo ultimo album "Rough And Rowdy Ways", uscito in piena pandemia.
Niente, però, potrà mai scalfire il mito. Perché Bob Dylan non è più solo il menestrello folk, il bardo della controcultura americana, il padre del cantautorato moderno. È un’idea, un concetto, penetrato nella cultura occidentale con una pervasività unica e al tempo stesso indefinibile. Hanno provato goffamente a catalogarlo i giurati del Nobel per la Letteratura nel 2016, paragonandolo a Omero, Ovidio e ai visionari del Romanticismo. Ma niente, anche in quella prestigiosa sede, è andato per il verso giusto: dalla incredibile (e inspiegabile) assenza del protagonista all’emozionatissima performance di Patti Smith, delegata a ritirare il premio in sua vece. Perfino una veterana come la sacerdotessa del rock si è impappinata per la commozione mentre intonava "A Hard's Rain A-Gonna Fall". Forse perché avvertiva sulle spalle il peso di quella cupa profezia, con cui un ventunenne Dylan preconizzava un’apocalisse imminente, tra decine di oceani morti e una gigantesca onda capace di affondare il mondo intero. Sinistramente attuale, oggi come (e più di) allora.
Tutto, in Bob Dylan, è mitologia. Oggi come sessant’anni fa, quando sbarcò a New York per suonare nei locali fumosi del Greenwich Village sulle orme del suo idolo Woody Guthrie. Era già circondato da un’aura mistica, da predicatore visionario. Come ebbe a raccontare un giovane Francesco De Gregori, il suo massimo discepolo italiano: “Dylan non cantava, lui sputava le parole come sassi, non cercava d’essere piacevole, al contrario. Come tutti i grandi artisti, non dava l’impressione di voler parlare a qualcuno, ma di parlare a nome di qualcuno. Magari a nome di una generazione”. Eppure proprio Dylan, anni dopo, avrebbe affermato: “Nessuno canta il blues come Blind Willie McTell”. Come a ribadire che l’autenticità non è qualcosa che si può insegnare. Del resto, è lui stesso contraddizione vivente: l’uomo che più ha incarnato il folk e che più lo ha tradito, almeno secondo i tradizionalisti, che ancora non gli perdonano l’abiura del Newport Folk Festival del 1965, quando scelse una dimensione elettrica per il suo set, contravvenendo ai sacri dogmi del genere. Doveva essere la sua fine, è stato il suo nuovo inizio. Perché, come araba fenice, Dylan rinascerà sempre: non lo fermerà il misterioso incidente di moto del 1966 e nemmeno la pericardite che nel 1997 lo spedirà in ospedale, ma senza impedirgli di riprendersi in tempo per cantare davanti a papa Woityla al Congresso Eucaristico di Bologna.
Fin dagli esordi, mister Zimmerman ha palesato le sue principali influenze: la Bibbia, le leggende della Frontiera, poeti epici come Walt Whitman. Intrisa di un’essenza religiosa, già dai tempi dei suoi primi "talking blues", la sua opera è tutta uno sguardo visionario sul mondo, tra inni pacifisti, come la celebre “Blowin’ In The Wind” (nata da un canto degli ex-schiavi neri che si erano arruolati nell’esercito yankee ai tempi della Guerra civile), affreschi allucinati (“Desolation Row”), anatemi contro le forze del male ("Masters Of War") e odi a misteriose figure celestiali (“Sad-Eyed Lady Of The Lowlands”).
Impossibile citare tutti gli album fondamentali dei suoi sei decenni sulla cresta dell’onda. Ma non si può certo non rimarcare l’importanza cruciale di lavori come “The Times They Are a-Changin'” (1964), “Highway 61 Revisited” (1965), “Blonde On Blonde” (1966), “Blood On The Tracks” (1975), “Desire” (1976), “Infidels” (1983), “Oh Mercy” (1989), “Time Out Of Mind” (1997). “Tempest” (2012). E non è altresì consentito ignorare l’impatto inter-generazionale avuto da canzoni come “Like A Rolling Stone”, “Mr. Tambourine”, “Just Like A Woman”, “Knockin’ On Heaven’s Doors”, “Lay Lady Lay” o la tempestosa “Hurricane”, in cui immortalò la storia del pugile nero Rubin Carter ingiustamente accusato di omicidio e condannato all'ergastolo. Chissà se aveva in mente proprio quel brano, Barack Obama, quando disse di lui "Non c'è gigante più grande nella storia della musica americana", consegnandogli nel 2012 la Medaglia della Libertà, dopo averlo invitato due anni prima a cantare alla Casa Bianca con Joan Baez, la musa dei suoi vent'anni, per un concerto "colonna sonora" delle marce per i diritti civili.
Dylan però ha sempre respinto le etichette (“It Ain’t Me, Babe”: non sono quello che credete io sia), a cominciare da quelle politiche, così come rifiuta "che la sua carriera venga imbalsamata", come scrive Paul Morley in "You Lose Yourself You Reappear", uno dei nuovi libri che celebrano la ricorrenza, aggiungendosi a un catalogo di oltre 4.000 scritti su di lui, per non parlare dei documentari, di cui ben due firmati da Martin Scorsese. Nel frattempo continuano a uscire a raffica le “Bootleg Series”, raccolte di materiale alternativo o inedito, tra cui le sorprendenti collaborazioni country con Johnny Cash o il capitolo dedicato alle registrazioni con George Harrison, pubblicato solo qualche settimana fa.
Ma ogni istantanea dell’uomo è illusoria, perché Dylan contravviene sistematicamente alle aspettative del pubblico, come quando nei live distorce le sue canzoni, rendendole irriconoscibili, come quando cambia inesorabilmente ad ogni disco il suo “thin, wild mercury sound”.
La sua lezione è stata il passepartout per le carriera di migliaia e migliaia di cantautori disseminati sulla Terra. Un patrimonio che non è neanche lontanamente quantificabile nel “tesoretto” incassato in carriera: 125 milioni di dischi venduti, dieci Grammy e l'Oscar nel 2001 per "Things Have Changed" dal film "Wonder Boys". Eppure, il Never Ending Bob – per citare il suo celebre slogan-filosofia del tour infinito – non resta mai con le mani in mano.
Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Maggio 2021, 16:06
© RIPRODUZIONE RISERVATA