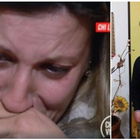«Mi è andata bene. Io in terapia intensiva ci sono entrato e sono uscito dopo quattro giorni, ma di Covid si continua a morire, e tanto. Finché non ci saranno cure e vaccini quella mascherina non si deve togliere».
A parlare è il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, che nel fine settimana è stato dimesso dall'ospedale Civile. Ha contratto il Covid e ne è uscito, ma l'esperienza è stata traumatica e ora considera una missione pubblica raccontare cosa ha passato per aiutare a vedere la realtà a chi ancora oggi si ostina a non volerla vedere.
Signor Prefetto, è stata una bella batosta...
«Ho perso nove chili e mezzo in 13 giorni, per lo più muscoli, ho qualche piccolo disagio addosso, ma cammino, mi muovo e sto facendo ginnastica. Il Covid è una batosta non solo fisica, non so che segni mi lascerà. Mi hanno detto che segna le persone in modo indelebile e credo sia vero, torni da un posto nel quale tanti non ce la fanno».
Come è iniziata?
«Una ventina di giorni fa, sarà stato il 7-8 di novembre, avevo cominciato ad accusare qualche sintomo influenzale: mal di schiena un po' di febbre mal di testa. Niente di importante, così almeno sembrava. Però mi ero detto, Eccolo qua, domani faccio il tampone. Era positivo».
E dopo?
«Son rimasto a casa e come mi hanno detto ho trattato i sintomi con le solite cose che si prendono con l'influenza. Dopo una settimana la situazione non cambiava, anzi era comparsa una tosse secca, ma non fastidiosa. Un giorno però ho avuto un collasso e sono svenuto per qualche istante. Ho chiamato il medico, che mi ha sentito i polmoni e mi ha spedito subito al pronto soccorso».
In ospedale è andata meglio?
«Mi hanno ricoverato nel reparto Covid ricavato in Medicina, sono stato lì un paio di giorni, poi la situazione è peggiorata, per cui hanno valutato di mandarmi in terapia intensiva dove sono stato 4 giorni. Lì, con il casco, la situazione è migliorata rapidamente e mi hanno riportato in reparto dove sono rimasto per altri sei giorni. Totale, 13 giorni in ospedale».
Che ricordo ha della terapia intensiva?
«Ho capito perché la gente si dispera e si lascia andare. Con il casco, chiuso in una stanza pieno di aghi e sensori, sono condizioni che ti intimidiscono che ti fanno paura, per quello c'è gente che si dispera. Io non ero in una condizione difficile, avevo un margine di respirazione autonoma. Il primario e il personale mi hanno spiegato che il casco aiuta ma ci devi mettere anche del tuo e non aspettare che esso respiri per te.
Come ha superato quella situazione?
«In tutti e due i reparti (Medicina e Terapia intensiva) ho trovato un senso di sicurezza e protezione che mi ha tolto l'ansia. Certo, c'è stato anche un momento di disperazione, ma per fortuna è passato. Ci vuole anche tanta forza per stare lì dentro. Sei inchiodato al letto, con tre aghi che monitorano tutto e ti nutrono. Ma c'è una caratteristica che secondo me a la differenza: l'approccio umano e cortese, la voce bassa, quasi suadente. Proprio tutti osservano questo protocollo di stile. Ti accarezzano la mano ogni volta che passano, chiedono come stai, ti spiegano. In questo modo ti levano l'ansia. Il fatto di mettere il paziente nelle condizioni di aiutarsi è certamente anche il frutto di una scelta strategica della direzione generale e dei reparti. Tutti hanno questo stile e io sono uno che osserva».
Però lei è il prefetto, una persona conosciuta.
«Solo i due primari sapevano chi ero, tutti gli altri non lo sapevano e mi parlavano in dialetto e io rispondevo allo stesso modo. Questa cosa mi ha inorgoglito, perché il protocollo deve essere uguale per tutti e questo va ancora più a merito della struttura che è abituata a lavorare in quel modo. Per questo vorrei ricordare qualche persona: i primari Andrea Bonanome (Medicina) e Marco Meggiolaro (Rianimazione), Fabio Gracetta (direttore dell'ospedale) e poi il direttore generale Giuseppe Dal Ben che ha fatto funzionare tutto questo. E poi le dottoresse Nogara e Maggiolo che mi hanno seguito in reparto. L'ospedale funziona bene, è adeguato anche a questa emergenza. In pochi giorni hanno ricavato 20 posti Covid in Medicina. Da soli».
Che messaggio vorrebbe lanciare?
«Il Covid è una malattia infida, all'inizio non stai tanto male e intanto i polmoni si riempiono e alla fine in tanti non ce la fanno. State attenti, dico, perché si muore per davvero. Quando il presidente Zaia dice che bisognerebbe portare certe persone là dentro, dice una cosa giusta anche se questo non è possibile. Bisognerebbe dare uno shock alle persone perché solo se si spaventano capiscano».
Come vede la situazione in Veneto?
«Mi pare che l'indice di contagio sia calato, ma mi sembra una storia già vista. Appena si sente una notizia del genere la gente si lascia un po' andare. Il virus non è però andato via, ma continua a fare morti. Anzi, l'andamento dei morti è stabile. Non è finita. Quelli che dicono che il Covid non c'è pensano solo a se stessi, ma il virus colpisce anche loro, non guarda in faccia a nessuno, siano essi prefetti, capi di Stato o no-mask. Guardate me: sono stato sempre attento, portavo la mascherina, facevo riunioni solo sul web eppure l'ho preso. Col senno di poi, credo di essermi salvato grazie al collasso, che è stato il campanello di allarme. Altrimenti non so come sarebbe andata a finire».
Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Dicembre 2020, 09:12
© RIPRODUZIONE RISERVATA