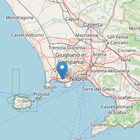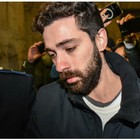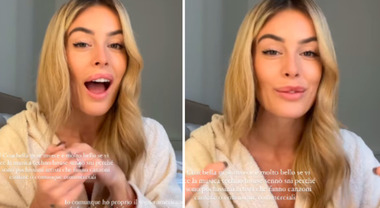Ronson: «Così riporto in discoteca la grande musica nera»
di Enzo Gentile
Parliamo dei collaboratori del disco?
«Michael Chabon, vincitore di un Pulitzer e del premio Pivano, ha lavorato allo storytelling seguendoci anche in studio di registrazione. te delle canzoni (ma non del singolo con Bruno Mars). Poi ci sono le voci di Kevin Parker (anche alla batteria, le chitarre ed i synth), Andrew Wyatt dei Miike Snow (anche autore), Keyone Starr, ventitreenne cantante di gospel scoperta a Jackson, nel Mississippi. Poi un mucchio selvaggio di produttori e musicisti miei amici da sempre».
Ci racconta la sua formazione musicale?
«Provengo da una famiglia musicale, conosco da bambino Nile Rodgers, che era amico di famiglia: inevitabile che per me lui sia un faro, un mito assoluto. Nel corso della mia gioventù mi sono spesso chiesto perché mi piacessero certi dschi di Madonna o di Duran Duran, di David Bowie o degli INXS o degli Chic e la risposta era sempre il suo comune denominatore, la chitarra e la produzione di Nile Rodgers. Poi ho avuto la fortuna di avere un padrino come Mick Jones, dei Foreigner, che mi avviò ai segreti e ai piaceri dello studio di registrazione. Ma anche la mia costanza, la mia curiosità a scavare tra le pieghe della musica, come fan, e poi nei locali, hanno avuto un ruolo determinante».
Il suo successo di artista è secondo solo a quello di produttore: qual è il mestiere che preferisce? E chi avrebbe desiderato produrre?
«Un punto di arrivo sarebbe stato produrre Stevie Wonder, ma quelli come lui sono personaggi di un’altra categoria, autentici geni, che possono tranquillamente fare a meno di me. E comunque ho avuto la fortuna di invitare Stevie in questo mio disco, un colpo fantastico sentirlo in studio a suonare l’armonica per un mio pezzo. Se guardo all’indietro con la macchina del tempo, direi che mi sarebbe piaciuto lavorare con Notorius B.I.G., e anche fare un altro disco con Amy Winehouse. Quanto a me, continuo a considerarmi un buon artigiano, e mi sento un produttore, che ogni tanto si prende una licenza da solista: uno come Pharrell Williams è un’altra cosa. Lui è frontman, io posso stare anche dietro le quinte».
Lei ha partecipato di recente come ospite di importanti griffe alle sfilate di moda milanesi e parigine: sente un legame con la sua musica?
«Lo stile, la moda e la musica con i suoi personaggi spesso hanno vissuto in simbiosi, ma non si tratta di una condizione meccanica. Dipende anche cosa ci sta dietro, come interagiscono questi mondi. Il Bob Dylan che si aggirava al Greenwich Village, con il giaccone di cuoio e gli stivali avrebbe dato una impronta insignificante se non ci fossero state le sue canzoni. Io ho visto il momento più alto e trendy del locali newyorkesi, quindici-vent’anni fa».
Erano i tempi di Jay-Z, Puff Daddy...
«E la musica era al centro, oggi la sua importanza, per il costume, mi pare un po’ sfumata. Biggie, Chaka Khan, Amerie, Boz Scaggs, Missy, Earth Wind & Fire, N.O.R.E facevano scatenare il dancefloor. I club erano pieni di ragazze e ragazzi, ballerini, spacciatori, rapper, modelle e skateboarder. Prima degli smartphone, del tavolo riservato e delle leggi antifumo, la gente rimane nel locale, totalmente assorbita dalla musica. Con “Uptown Special” ho voluto catturare la sensazione che ricordo di quelle serate a New York».
Quanto Internet ha modificato l’ascolto, forse anche la creazione, della musica?
«Il dibattito è aperto. Prendiamo per esempio Spotify: è un vantaggio o un danno per la diffusione della musica? Io so di certo che vorrei per i miei figli un futuro in cui le possibilità si spalanchino e godano della massima libertà di circolazione: e per questo, da Internet non si può prescindere».
Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2015, 23:32